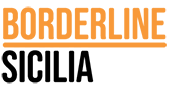Ricongiungimenti familiari per i rifugiati
Una procedura “facilitata” solo sulla carta
Il nostro ordinamento tutela l’unità del nucleo familiare dei beneficiari dello status di rifugiato e protezione sussidiaria. Questo dice la legge all’art. 22 del d. lgs. 251/2007, recante la disciplina dell’attribuzione e del contenuto della protezione internazionale.
Eppure, tale tutela sembra rimanere solo sulla carta. Per i titolari di protezione internazionale – che fuggono dai loro paesi a causa di gravi persecuzioni personali o di situazioni di violenza generalizzata – la normativa prevede una procedura agevolata per il ricongiungimento con i familiari rimasti nel Paese di origine. Tuttavia, nella pratica – come abbiamo avuto modo di constatare – l’arrivo dei congiunti in Italia è spesso reso complicato dalla burocrazia e dall’ostruzionismo delle ambasciate italiane all’Estero.
Il Testo Unico sull’Immigrazione, che disciplina in generale la possibilità per gli stranieri con permesso di soggiorno in Italia di chiedere il ricongiungimento familiare, prevede che questo possa essere chiesto in riferimento a determinate categorie di familiari: il coniuge; i figli minori, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; i figli maggiorenni a carico, qualora non possano provvedere a se stessi a causa di un’invalidità; i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine, ovvero i genitori ultra sessantacinquenni, qualora gli altri figli per motivi di salute non vi possano provvedere.
Per ottenere il ricongiungimento, lo straniero soggiornante in Italia deve presentare, con modalità informatiche, domanda di nullaosta alla prefettura competente, che rilascia il nullaosta o un provvedimento di diniego dello stesso entro 90 giorni dalla richiesta.
Anche i rifugiati e i beneficiari di protezione sussidiaria possono chiedere il ricongiungimento familiare per le richiamate categorie di familiari seguendo la procedura di cui al Testo Unico. Tuttavia, proprio per accelerare ed agevolare le procedure, essi non sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti di alloggio e di reddito.
Successivamente, sarà l’autorità consolare italiana a rilasciare il visto al familiare per il quale è stato concesso il nullaosta dalla prefettura, affinché possa fare ingresso in Italia. Il rilascio del visto è subordinato alla presentazione della domanda attraverso gli uffici di una società privata a cui le ambasciate affidano tali procedure, ed all’effettivo accertamento dell’autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute da parte dell’autorità consolare.
Anche in tal senso la normativa prevede una procedura specifica per i titolari di protezione internazionale, i quali spesso incontrano difficoltà nell’ottenere documenti ufficiali che provino i loro vincoli familiari a causa della mancanza di un’autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall’autorità locale. In tal caso, le rappresentanze diplomatiche o consolari possono rilasciare certificazioni sulla base delle verifiche ritenute necessarie effettuate a spese degli interessati. È prevista inoltre la possibilità di far ricorso ad altri mezzi per provare l’esistenza del vincolo familiare, come documenti rilasciati dagli organismi internazionali o la prova del DNA. In ogni caso, la normativa precisa che il rigetto della domanda di ricongiungimento presentata dai titolari di protezione internazionale non può essere motivato unicamente dall’assenza di documenti probatori.
Questa, sulla carta, è la procedura – facilitata – per ottenere il ricongiungimento familiare e così tutelare l’unità dei nuclei familiari dei titolari di protezione internazionale.
L’esperienza, però, ci mostra una realtà ben diversa, di cui sono responsabili le stesse autorità del nostro Paese.
La storia di una rifugiata ivoriana
Una realtà diversa è, ad esempio, quella vissuta da F. che, dopo essere giunta nel nostro paese dalla Costa d’Avorio insieme alla figlia più piccola, si vede riconosciuto dalla commissione territoriale lo status di rifugiata. F. ha lasciato in Costa d’Avorio i due figli più grandi, non potendo permettersi di intraprendere il viaggio con tutti loro. Per questo, una volta ottenuti i documenti in Italia, ha iniziato la procedura per il ricongiungimento con la figlia M., quasi diciassettenne, ottenendo senza problemi il nulla-osta della prefettura.
Tuttavia, come se non bastassero il dolore di aver lasciato indietro i propri figli, e l’impossibilità di ottenere il consenso del padre violento affinché anche il figlio dodicenne potesse lasciare la Costa d’Avorio e raggiungere la madre in Italia, i funzionari delle nostre ambasciate hanno aggiunto un ingiustificato aggravamento della procedura di rilascio del visto per la figlia diciassettenne.
Ci racconta F. che anche entrare in ambasciata è difficile. Nonostante fossero stati presi degli appuntamenti e fosse stata inviata una pec dall’avvocato per segnalare l’alto grado di vulnerabilità della ragazza e l’urgenza del suo ricongiungimento con la madre, data la situazione di pericolo vissuta in Costa d’Avorio, le è stato più volte negato l’ingresso, costringendola a rifare ripetutamente il viaggio di andata e ritorno dal paese dove viveva, perché non veniva ricevuta o perché le venivano chiesti documenti non necessari o che lei non poteva avere.
All’interno degli uffici, inoltre, non vi era un traduttore e le è stato parlato spesso in italiano, con l’ulteriore difficoltà di non poter comunicare con l’esterno – con la madre o con l’avvocato italiano – a causa dell’obbligo di lasciare il telefono all’ingresso in ambasciata.
Le richieste dei funzionari, poi, risultavano per lo più pretestuose, volte unicamente a procrastinare il rilascio del visto, a cui M. avrebbe avuto diritto sin da subito. La ragazza ha ricevuto un preavviso di rigetto della domanda di visto per non aver presentato il certificato di nascita tradotto e legalizzato. Una volta richiesta, attraverso l’avvocato, le legalizzazione del documento da parte dell’autorità consolare come previsto dalla legge, le viene detto oralmente che il documento doveva essere necessariamente autenticato dai ministeri degli Esteri e dell’Interno della Costa d’Avorio, rendendo necessario l’intervento dell’avvocato per diffidare l’ambasciata a porre fine a tali richieste illegittime.
Non tutti hanno l’opportunità, la possibilità, la fortuna di avere un’associazione ed un avvocato in Italia che segua, passo dopo passo, la procedura di ricongiungimento familiare. Cosa succede a chi si trova da solo davanti al “muro” delle ambasciate?
La storia di un rifugiato guineano
Anche quella vissuta da T., è un’esperienza decisamente distante da quelli che sulla carta sono i diritti dei rifugiati.
Proveniente dalla Guinea, T. – perseguitato nel suo Paese per motivi politici – è arrivato in Italia nel 2015, ma ha ottenuto lo status di rifugiato solo dopo anni; la commissione territoriale gli aveva inizialmente riconosciuto la protezione umanitaria, che non permette di chiedere il ricongiungimento familiare.
Dopo aver finalmente ottenuto lo status di rifugiato dal tribunale, T. inizia la procedura per far venire in Italia la moglie e i due figli minori, lasciati in Guinea e anch’essi in pericolo in quanto familiari di un oppositore politico.
Anche in questo caso nessun problema si è posto per ottenere il nullaosta dalla prefettura in Italia. Diverso, lungo e pieno di ostacoli è stato, invece, il percorso per ottenere il rilascio del visto da parte dell’ambasciata italiana in Senegal, la rappresentanza diplomatica competente anche per la Guinea.
Come per la figlia di F., anche in questo caso il primo “errore” dei funzionari dell’ambasciata è stato quello di dichiarare la loro impossibilità di procedere alla legalizzazione dei documenti. Ma questo non bastava. L’ambasciata ha chiesto anche l’autorizzazione al viaggio per i figli minori da parte del padre, ossia colui che aveva avviato la procedura di ricongiungimento proprio per far viaggiare i propri figli minori, assieme alla moglie, verso l’Italia. Eccesso di zelo? Anche a questo T. e la moglie hanno provveduto.
Ma non bastava ancora. Alla moglie di T. viene richiesto di avere la prenotazione aerea, senza la quale – sostengono gli uffici dell’ambasciata – rilasciare il visto per il viaggio non è possibile. Anche questo non è vero: per alcuni tipi di visto l’avere una prenotazione aerea è un presupposto, ma non è questo il caso. Anche in tale circostanza si tratta di una richiesta pretestuosa volta solo a posticipare, a rimandare a tempo indefinito l’ottenimento di un visto cui la moglie di T. e i due bambini avevano diritto.
A questo punto la donna con i due bambini ha ripreso appuntamento presso gli uffici dell’ambasciata per richiedere il visto, con tutta la documentazione – necessaria o meno – che le era stata richiesta. In quell’occasione le sono stati chiesti più soldi di quanti lei ne avesse e allora è uscita per andare a prenderli e ha chiesto la cortesia di poter lasciare lì i due bambini. Sarebbe tornata subito, appena presi i soldi. Quando è tornata, però, i funzionari dell’ufficio l’hanno accusata di aver abbandonato i figli chiarendole che loro non sono un servizio di baby-sitting. Sono gli stessi funzionari che precedentemente le avevano premurosamente offerto il proprio aiuto per compilare i moduli necessari al posto suo. In cambio di soldi.
Dopo ciò la moglie di T. viene mandata via. Un nuovo appuntamento le verrà concesso solo due settimane dopo, grazie all’intervento dell’UNHCR. La donna riesce quindi, finalmente, a presentare la domanda per il visto.
Tuttavia, passano i 30 giorni previsti dalla legge e questo visto non viene rilasciato. Anche in questo caso si è reso necessario l’intervento dell’avvocato che dall’Italia ha proceduto a una diffida. Una settimana dopo la moglie di T. ha ottenuto il visto e si è finalmente conclusa l’odissea del loro ricongiungimento. Tra i vari disagi subiti, la permanenza in Senegal della signora insieme ai bambini, ha comportato un’enorme spesa economica.
Prassi illegittime e veri e propri abusi da parte delle ambasciate italiane
Queste sono “solo” due storie, si potrebbe pensare. Tuttavia è bene fermarsi a riflettere sul fatto che queste sono le storie di due famiglie “fortunate”.
Perché sono state seguite da un’associazione che attraverso un legale, pur con tutte le difficoltà dovute alla distanza, è riuscita a sollecitare gli uffici, individuare le prassi illegittime, denunciarle a chi di competenza e, in definitiva, adottare tutte le misure necessarie a tutelare davvero quei nuclei familiari.
Che fine fa chi non ha questa “fortuna”? Non tutti hanno l’aiuto di cui avrebbero bisogno per comprendere in primis che quello che stanno subendo è un abuso e poi per opporvisi e ricevere una tutela adeguata dei propri diritti.
Il ritardo – non giustificato – nel rilascio di un visto ai familiari di rifugiati e titolari di protezione sussidiaria, oltre ad essere un vero e proprio abuso, comporta un aggravamento della situazione di pericolo in cui già si trovano queste persone che avrebbero invece diritto ad una celere messa in sicurezza. Inoltre, ci chiediamo quali siano i meccanismi di controllo nei confronti delle prassi adottate dai funzionari delle ambasciate italiane all’Estero, visto che le procedure non sembrano funzionare secondo quanto prevede la legge.
Dobbiamo chiederci quanti cadono nella rete di abusi e ostruzionismo messa in piedi da funzionari del nostro Stato, che fuori dai confini nazionali pensano di poter agire non visti, approfittando della situazione di bisogno di chi a loro si rivolge per ottenere, né più né meno, quello che gli spetta.
Valeria Pescini
Borderline Sicilia