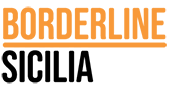Una barricata nel limbo: gli occupanti del centro “La Locanda”
Sono
arrivato con gli altri bianchi. Due auto della polizia si sono fermate
all’inizio della strada e si è formata una folla attorno a un blocco stradale
improvvisato che fermava i veicoli che entravano nel viale che porta alla
struttura.
Il centro di
accoglienza “La Locanda” si trova a circa due ore a piedi da Castelvetrano e a
un’ora da Marinella di Selinunte. Tutt’intorno si estendono desolati terreni
agricoli. Situato proprio in mezzo al nulla, ospita circa 100 ragazzi che
provengono dall’Africa occidentale e dal subcontinente indiano. Alcuni di essi
sono rimasti qui ad aspettare per quasi due anni. Tale periodo di attesa è
imposto loro dal lentissimo sistema d’accoglienza italiano per quanti chiedono
protezione internazionale, il che significa che un centro designato ad ospitare
persone per solo pochi mesi alla volta è diventato un sostegno istituzionale
per decine di ragazzi, i quali si affidano ad esso per l’assistenza per
ottenere i documenti.
Le uniche
pause nel loro soggiorno sono quelle costituite da brevi permessi di viaggio –
durante i quali non ricevono la consueta ‘paghetta’ – o dai più faticosi dei
lavori. In ogni caso, la permanenza in tale centro non è obbligatoria: in
effetti essa non aumenta nemmeno le loro probabilità di ricevere asilo.
Tuttavia si tratta dell’unico sistema statale di supporto disponibile per
costoro: naturalmente, con la mediazione di aziende private. D’altronde, una
volta registrati presso il centro, esso diventa il loro domicilio ufficiale
dove ricevere la posta. Mentre passano i mesi, il tempo investito nell’attesa
diventa esso stesso una ragione per restare, perfino in centri che avrebbero
decisamente bisogno di essere migliorati o chiusi.
Quella per i
documenti è dunque in realtà una lotta per uscire da una situazione difficile.
Lo scorso lunedì pomeriggio la situazione è precipitata quando uno dei ragazzi
ha richiesto ancora una volta informazioni sui suoi documenti e il manager ha
perso la calma. Gli occupanti mi dicono che quella è stata la classica goccia
che ha fatto traboccare il vaso. Il mattino dopo, i presenti nel centro (circa
60 persone, mente circa altri 30 erano in permesso di viaggio) hanno deciso di
espellere gli operatori e barricare il viale, in segno di protesta contro i
lunghissimi tempi di attesa per i documenti, quel sigillo ufficiale che sentono
tanto necessario per continuare a vivere e a fare progetti. Ciò che esigono è
che la polizia di Trapani (che è il posto in cui tutti hanno rilasciato le loro
dichiarazioni allo scopo di richiedere l’asilo) venga al centro per discutere
le loro situazioni. Per “polizia”, gli occupanti intendono piuttosto quanti
presiedono all’iter burocratico delle loro richieste, per quanto non mi fosse
mai chiaro a chi esattamente le avessero indirizzate. Le situazioni da
risolvere, dicono gli occupanti, possono essere divise nel modo seguente:
quella degli ospiti che hanno ricevuto risposte negative ma che successivamente
hanno saputo poco o nulla dei loro appelli; quella di coloro che hanno ricevuto
risposte positive ma non hanno ancora materialmente ricevuto i documenti
indispensabili a viaggiare; e quella di quanti sono ancora in attesa.
All’interno
di quest’ultima categoria c’è Abab, un giovane pakistano che ormai da tre mesi
aspetta una decisione sulla sua richiesta di asilo, nonostante le linee-guida
fornite agli ospiti dichiarino che essi debbano ricevere risposta entro un mese
e mezzo dall’intervista presso la commissione trapanese. Abab mi parla dei suoi
problemi cardiaci, che sono cominciati dopo il suo arrivo in Italia,
dell’infarto che ha subito, e della sua delusione riguardo alle cure che
riceve. “Il prossimo appuntamento ce l’ho fra sei mesi!”, lamenta. “Se muori
prima di un appuntamento, ti chiedo, chi ci va al tuo posto?”
La lamentela
di Abab, per quanto ovviamente enfatizzata dallo stress della situazione in cui
vive, ci parla più in generale dei problemi dei servizi pubblici in Sicilia –
anche per gli italiani sei mesi di attesa non sarebbero inusuali. D’altra parte
i problemi economici italiani non sono affatto sfuggiti all’attenzione degli
occupanti durante questi mesi, questi anni: un giovane gambiano gesticola verso
i suoi compagni intorno a noi e mi dice che quanti rimangono nel centro sono
quelli che non possono raggiungere parenti o amici in altri paesi. La maggior
parte degli ospiti che hanno ricevuto risposte negative dalla commissione sono
già partiti per la Germania, preferendo l’illegalità al rimpatrio.
Mentre molti
hanno lasciato il centro, nuovi arrivati continuano a riempirlo. Un giovane
nigeriano mi racconta di essere stato trasferito da poco a La Locanda da un
centro con circa 50 persone a Piana degli Albanesi, chiuso alcune settimane fa,
i cui ospiti all’inizio sono stati portati a Trapani: “Ho visto prigioni
migliori”, dice. Hanno rifiutato di starci, e in segno di protesta si sono
accampati davanti alla questura. Due settimane dopo si ritrova qui, in mezzo ad
un’altra protesta. È convinto che lui e i suoi compatrioti siano trattati
così male, “come schiavi”, a causa della loro pelle scura, e ha notato che i
siriani, più chiari, sembrano essere meglio accolti in Europa.
Il maltrattamento al centro non ha a che fare soltanto
con la mancanza di documenti. Emerge una quantità di lamentele: niente
televisione per passare il tempo; wifi insufficiente per stare in contatto con
le famiglie (molti hanno figli in patria); una generale sfiducia nelle cure
mediche che ricevono; che gli viene servita ogni giorno pasta “buona soltanto
per dei bambini”. Che sembra impossibile contattare gli avvocati. Che non c’è
abbastanza shampoo. Può sembrare che chiedano cose che vanno oltre il livello
della “schiavitù”, per quanto indispensabili nella vita moderna. Tuttavia
ognuna di esse va vista nel contesto della apparentemente eterna attesa dei
documenti, la zona grigia della vita vissuta in una sala d’attesa. A Tijan, un
altro giovane gambiano che indossa un cappello e una catena con i colori
dell’Etiopia, chiedo che cosa si aspettasse prima di arrivare in Italia.
Timidamente, con pacatezza, mi risponde che pensava soltanto di ottenere
velocemente i documenti e, “con l’aiuto di Dio”, trovare lavoro.
Bloccare le strade era il tentativo di realizzare questi
desideri. Infatti quest’estate gli ospiti avevano già bloccato il viale per un
poco. Stavolta però hanno occupato anche l’edificio. Quando martedì mattina è
arrivato il furgone con i pasti, lo hanno mandato via, mentre si assicuravano
il possesso dei campi. In un primo momento gli occupanti hanno dichiarato alla
polizia di non volere consegne, ma quando hanno cambiato idea le consegne erano
state cancellate dal centro, con la scusa che il cibo potesse essere
distribuito soltanto dagli operatori. Ovviamente gli ospiti non sono d’accordo,
dal momento che si rendono perfettamente conto che si tratta di un tentativo di negoziare. Tra l’altro, la
protesta ha coinciso con la distribuzione della “paghetta” mensile di €75, il
che significa che non hanno avuto nemmeno abbastanza soldi per comprare da
mangiare.
Poco dopo il mio arrivo il negoziato con la polizia – fra
inconsistenti minacce di rimpatrio forzato – ha avuto come risultato che sono
stati ammessi nei campi alcuni agenti, insieme al manager, a un paio degli
operatori e a un traduttore. Un agente mi ha chiesto che cosa pensassi della
protesta, che cosa rappresentassero davvero le richieste. Sembrava credere che
la protesta fosse indirizzata contro gli operatori o il manager, piuttosto che
prendere le parole degli occupanti per quello che sono, ovvero che la loro
protesta è diretta contro le autorità trapanesi. Al di là delle critiche nei
confronti del centro, gli ospiti non hanno indirizzato la loro rabbia verso il
manager o gli operatori, ma piuttosto verso il sistema nel suo complesso.
D’altra parte sanno benissimo che altrove le cose non vanno affatto meglio.
La polizia ha chiesto che gli ospiti fornissero una lista
di coloro che protestavano per avere i documenti, cosa che gli occupanti hanno
subito interpretato come una richiesta dei nomi delle “teste calde”. Alla fine
comunque le due parti sono arrivate ad un accordo secondo il quale venerdì
mattina quattro rappresentanti sarebbero andati alla questura e avrebbero
esposto i problemi di ognuno degli ospiti, a condizione che se non ci fossero
stati progressi entro lunedì, avrebbero rioccupato l’edificio. Così giovedì
tutto era tornato alla normalità. È arrivato il furgone dei pasti, gli
operatori hanno distribuito il cibo. L’istituzionalizzazione, con la cultura
paternalista che implica, ha ricominciato il suo ciclo ripetitivo. La rottura
di tale ripetizione, l’emergere di una voce collettiva, è stata nuovamente
sommersa sotto i ritmi quotidiani di una vita di privazione.
Nel sistema di accoglienza italiano proteste di questo
tipo non sono nuove: sit-in e blocchi stradali sono frequenti, e nelle scorse
settimane a Lampedusa il potenziamento delle operazioni di identificazione
tramite rilevamento delle impronte digitali è stato interrotto da scioperi
della fame e manifestazioni. Coloro che sono coinvolti in queste attività, che
premono contro un sistema che li rende dipendenti da magre elemosine statali in
una nebbia di attesa senza fine, non hanno alcuna particolare rete, linguaggio
in comune e nemmeno le stesse posizioni legali. Forse il loro unico momento
unitario è costituito da questo: la differenza tra le aspettative di una vita
da condurre in Europa – con l’accesso a vere cure mediche, mercati del lavoro e
svaghi – e la realtà nella quale sono rimasti sospesi, nascosta alla vista
della società. Un limbo fra i fichidindia e gli uliveti, concepito per produrre
gente priva di documenti. Il divario tra questi due punti, l’umile sogno e
l’inquietante realtà, viene riempito dalle voci arrabbiate e intransigenti di
persone come gli occupanti di La Locanda, il cui coraggio potrebbe essere
l’unica speranza di mettere fine a tale sistema.
Richard Braude
Tradotto di Gabriele S.